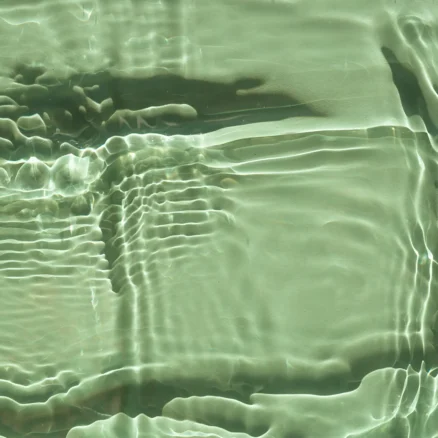Le foreste non sono semplicemente riserve di carbonio; conservano anche una memoria storica. Gli anelli di crescita di un albero racchiudono dati preziosi sull’ambiente atmosferico di periodi passati, fungendo da registro biologico degli interventi ambientali e dei ritardi nelle azioni climatiche.
Belém, porta dell’Amazzonia, ha rappresentato il contesto ideale per ospitare la Conferenza delle Parti del 2025 (COP30). Qui nel punto d’incontro tra foresta e oceano, il ciclo del carbonio si dispiega in tutta la sua complessità. Una ricerca recente, pubblicata su Atmospheric Chemistry and Physics (2025), indica che sebbene l’Amazzonia continui a fungere da serbatoio di carbonio, la sua capacità di farlo è sempre più precaria. In alcune aree, gravemente colpite dalla deforestazione e dallo stress idrico, le emissioni superano ormai l’assorbimento.
Le foreste indigene, che rappresentano circa un terzo del bioma e sono amministrate dalle comunità locali, continuano a fungere da sink netto, grazie alla preservazione della copertura forestale e a metodi di gestione tradizionale. Questi scenari mettono in risalto come le pratiche tradizionali di gestione del territorio possano continuare a favorire in modo concreto la stabilità climatica globale, come ribadito dal World Resources Institute.
La COP30 si è svolta in questo contesto complesso, che va oltre la geografia. Ha segnato un ritorno al cuore vivente della Terra: un momento per parlare apertamente dei limiti e delle possibilità. Dopo tre decenni di negoziati internazionali, l’Amazzonia ci ricorda che la politica climatica non può essere valutata solo in base agli obiettivi che si prefigge, ma anche in base al tempo stesso, al tempo che ci resta e al modo in cui scegliamo di utilizzarlo.
Sul tavolo a Belém
+ Finanza climatica: trasformare gli impegni in risorse
Con riferimento ai due tavoli di lavoro di COP30 – Formal Agenda ed Action Agenda ed ai numerosi livelli di discorso, a nostro parere due capisaldi sono stati rappresentati dalla finanza climatica e la protezione delle foreste. Il primo riguarda la capacità di tradurre le promesse politiche in strumenti concreti per i Paesi più vulnerabili. L’Independent High-Level Expert Group (IHLEG) ha delineato un piano per mobilitare 1,3 trilioni di dollari l’anno entro il 2035, con l’obiettivo di ridurre il divario tra le ambizioni climatiche globali e la capacità effettiva dei Paesi a basso e medio reddito di realizzare la transizione e adattarsi agli impatti del clima,
Secondo il Climate Policy Initiative (CPI), nel 2023 i flussi di finanza green ammontavano a circa 196 miliardi di dollari, una cifra ancora lontana da quanto necessario. Per colmare il divario è necessaria una combinazione di risorse pubbliche e private, difficile da mobilitare nel breve periodo. La Baku to Belém Roadmap to 1.3 T dell’UNFCCC, una mappa dettagliata delle opzioni di policy richieste per ridurre il gap, raccomanda, tra le altre proposte, di aumentare la quota di Official Development Assistance (ODA) fino allo 0,7% del PIL dei Paesi ad alto reddito e di ampliare la finanza pubblica sotto forma di sovvenzioni e prestiti agevolati, così da evitare di aggravare il debito dei Paesi con margini fiscali ridotti.
L’adattamento rimane un tema centrale. I Paesi partecipanti alla COP dovranno accordarsi su di un insieme di indicatori necessari al monitoraggio dei Global Goals on Adaptation (GGA), stabiliti a Parigi nel 2015. La finalizzazione di questi indicatori deve essere accompagnata da un chiaro impegno finanziario. Nei Paesi a basso reddito, ad esempio, i capitali privati rappresentano appena il 5% degli investimenti in adattamento, mentre l’evidenza scientifica mostra che questi interventi, pur generando rendimenti finanziari limitati, hanno ritorni sociali ed economici elevati nel lungo termine, riducendo disuguaglianze e povertà.
+ Le foreste tropicali: protezione e investimento
Accanto alla finanza climatica, la protezione delle foreste è stata la seconda grande priorità del vertice. Il presidente Luiz Inácio Lula da Silva ha presentato il Tropical Forest Forever Facility (TFFF): un fondo multilaterale da 125 miliardi di dollari affidato alla Banca Mondiale, ideato per sostenere in modo permanente i Paesi che custodiscono i grandi biomi tropicali, con l’obiettivo di proteggere 1,1 miliardi di ettari.
Il TFFF si affianca ai programmi REDD+, ampliandone la portata. Le risorse, provenienti da mercati finanziari e contributi statali, saranno destinate a 74 Paesi che insieme ospitano oltre un miliardo di ettari di foreste tropicali e sub-tropicali. I pagamenti saranno proporzionali ai risultati di conservazione: i fondi diminuiranno in misura maggiore rispetto alla perdita di copertura forestale. Il meccanismo prevede un monitoraggio satellitare a basso costo e destina almeno il 20% dei fondi alle comunità indigene e locali, riconoscendo così il loro ruolo cruciale nella tutela e nel ripristino delle foreste.
La COP30 si è distinta per la grande partecipazione, oltre che dei governi, anche dei rappresentanti delle comunità indigene e delle amministrazioni locali con più di tremila delegati presenti: da loro è giunta richiesta per il riconoscimento diretto dei territori indigeni nei piani nazionali di mitigazione e un accesso autonomo ai fondi climatici.
+ Ambizione e mitigazione
Il Global Stocktake 2023 aveva già mostrato che, nonostante i progressi, gli impegni attuali non bastano per mantenere il riscaldamento globale entro livelli compatibili con la stabilità del sistema climatico. Il UNEP Emissions Gap Report 2025 ribadisce la necessità di colmare rapidamente il divario tra i piani nazionali e le traiettorie compatibili con un aumento massimo di 1,5 °C rispetto ai livelli pre-industriali. Anche se le Nationally Determined Contributions (NDCs) fossero pienamente implementate, il pianeta si avvierebbe verso un aumento di 2,3–2,5 °C entro la fine del secolo. Per raggiungere il target di Parigi serviranno tagli rapidi e consistenti alle emissioni di gas serra, ma anche una forte espansione della finanza per l’adattamento.
Destinare risorse alla capacità di adattamento, infatti, non significa ridurre l’impegno per la mitigazione, ma riconoscere che entrambi gli approcci agiscono sullo stesso obiettivo: mantenere la stabilità climatica e limitare le perdite future. Senza dimenticare come il Belém Action Mechanism (BAM) tratteggi la rotta verso il terzo elemento, la Just Transition, che, pur essendo non prescrittivo, definisce un lessico comune e incentiva la cooperazione tra gli attori coinvolti nelle iniziative legate ad una transizione equa.
+ Le foreste come leva di equilibrio
Valorizzare il ruolo delle foreste significa agire alla radice del problema. Come serbatoi di carbonio e fornitori di servizi ecosistemici, dall’assorbimento di CO₂ alla regolazione delle precipitazioni, gli ecosistemi forestali restano fondamentali per stabilizzare il clima e sostenere le comunità che vi vivono. In questa prospettiva, il TFFF e le iniziative sulla finanza climatica rappresentano un passo verso la coerenza tra economia e natura. Il successo dipenderà dalla capacità di rendere questi meccanismi trasparenti, equi e misurabili nel tempo.
+ Per le imprese: dalla strategia all’attuazione
Per il settore privato, la COP30 ha confermato che il successo dell’azione climatica dipende dalla capacità di trasformare gli impegni in risultati concreti. Le aziende sono chiamate sempre di più a integrare criteri ambientali e climatici nei processi decisionali e di management del rischio, collaborare lungo la catena del valore e comunicare i risultati in modo trasparente. L’allineamento tra strategie aziendali e obiettivi climatici globali diventa così non solo un requisito di responsabilità, ma una leva per la competitività e la resilienza dei sistemi economici.
In conclusione
La COP30 di Belém ha offerto al mondo un’occasione per misurare la distanza tra ambizione e azione. Ha ricordato che la coerenza rimane una delle misure più concrete del progresso: allineare obiettivi, strumenti e risultati sarà la vera prova della credibilità dell’agenda climatica globale. Per ora, la foresta osserva. Assorbe, registra, attende, come un organismo che ricorda meglio di noi quanto sia sottile la distanza tra promessa ed azione.